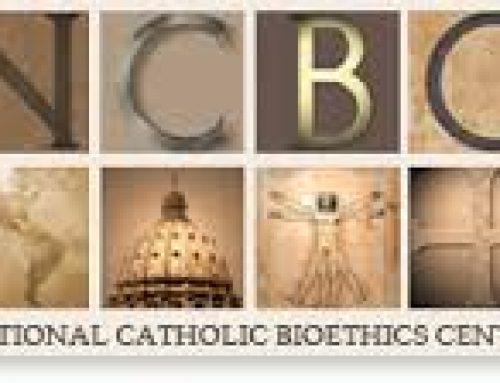28 settembre 2018
«Da ricercatore ero abituato a discutere, ipotizzare, a esprimere dubbi, a considerare l’impatto e la congruità della metodologia usata nell’esperimento. In clinica medica e soprattutto per quanto attiene alla prescrizione dei farmaci non trovavo traccia di questi momenti fondamentali». Se è un medico clinico a fare una simile affermazione vi è sicuramente più di un motivo per allarmarsi. Giorgio Dobrilla, gastroenterologo, si qualifica come tale nella prefazione a Farmaci sicuri, un agile e prezioso libro scritto da Silvio Garattini e Vittorio Bertelé e da poco pubblicato per i tipi delle edizioni Edra.
Fondatore e fino a poco tempo fa direttore dell’Istituto Mario Negri il primo, farmacologo clinico il secondo, i due autori e alcuni loro collaboratori conducono il lettore, anche il meno esperto, in un campo che meriterebbe di essere sicuramente più conosciuto, quello della sperimentazione clinica in farmacologia. Nel nostro paese si sta vivendo infatti un’epoca di grande sofferenza culturale anche da questo punto di vista e in qualche caso si sfiora il paradosso: qualcuno si rifiuta di vaccinare i figli prestando fede a teorie che nulla hanno di scientifico e nello stesso tempo la stessa persona corre il rischio di acquistare farmaci costosi, inefficaci e magari gravati di effetti collaterali perché messi in commercio per ragioni più di mercato che di reale valutazione dei benefici.
Il professor Garattini nell’introduzione lo dice chiaramente citando i recenti casi della cosiddetta “terapia Di Bella” (ancora incredibilmente prescritta da qualche medico), del “metodo Stamina” per il quale — scrive l’autore — «la scienza è stata vilipesa a favore di pseudo-ragioni compassionevoli» in grado di fuorviare completamente la parte meno informata della cittadinanza, e della cannabis per il trattamento di un’ampia (troppo ampia) serie di sintomi. In quest’ultimo caso — continua Garattini — «il Parlamento con una legge ad hoc ne ha approvato l’impiego delegando un’istituzione pubblica alla coltivazione della pianta e alla preparazione del preparato farmaceutico senza le necessarie ricerche preliminari e senza l’autorizzazione dell’organo deputato all’approvazione dei farmaci, l’Agenzia italiana per il farmaco (Aifa)».
Quale può essere la risposta adeguata per trasformare il farmaco da “bene di consumo” a “strumento di salute” e per diffondere tra i cittadini un’immagine corretta della ricerca e della sperimentazione in un campo, quello dei medicinali, il cui mercato raggiunge nel mondo la cifra di duemila miliardi di euro e che in Italia è vicino ai trenta miliardi di euro, i due terzi dei quali rimborsati dal servizio sanitario nazionale?
Il libro espone chiaramente alcune possibili soluzioni. La prima è di tipo giuridico: «la legislazione europea che stabilisce i criteri generali per l’approvazione di un nuovo farmaco tiene in maggior considerazione gli interessi di mercato rispetto al benessere degli ammalati» e un farmaco può essere approvato sulla base della qualità, della sicurezza e dell’efficacia senza tenere in alcun conto il «valore terapeutico aggiunto», la superiorità cioè del nuovo farmaco su quelli simili già esistenti, superiorità stabilita «sulla base di un reale vantaggio per i pazienti». Puntare anche sul valore terapeutico aggiunto porterebbe ad eliminare dal mercato molti farmaci cosiddetti me too, inutili e costose copie di altri già esistenti.
La seconda soluzione tocca da vicino la ricerca, sia preclinica che clinica: gli studi «sono calibrati — si legge — per studiare i benefici dei farmaci mentre in genere sono insufficienti a svelare tutti gli effetti tossici». Il grande medico canadese William Osler insisteva sul fatto che «No drug has a single effect» (“nessun farmaco ha un effetto soltanto”): poche riviste sono dedicate alla tossicologia, poco considerati e supportati i ricercatori che si occupano di tossicità dei farmaci, e questo in nome di una spasmodica e interessata ricerca dei benefici che possono spingere la molecola sul mercato. Occorre un’inversione di tendenza ed è sempre più necessario «un potenziamento di forme di farmacovigilanza attiva».
La terza strada da percorrere sarebbe quella, suggeriscono gli autori, di promuovere maggiormente la ricerca indipendente, quella non condotta dall’industria farmaceutica. A fronte dei «miliardi di euro investiti dall’industria sono solo pochi i milioni di cui può fruire la ricerca indipendente» la quale, se adeguatamente affiancata a quella industriale, potrebbe anche far risparmiare agli stati molti soldi evitando molti farmaci inutili da rimborsare.
“Randomizzazione”, “studi in doppio cieco”, “trials controllati”, “placebo”: se questi termini diventassero un po’ più familiari ai cittadini crescerebbe senza dubbio la sensibilità per tematiche avvertite come ostiche e lontane e forse aumenterebbe anche la voglia di partecipare allo sviluppo di nuovi farmaci. «La domanda deve essere vera e la risposta affidabile»: questa è la massima che dovrebbe guidare la ricerca in genere e quella farmacologica in particolare.
Il libro si conclude con la sottolineatura di alcune iniziative che, a livello europeo, cercano di perseguire questa svolta culturale. Tra queste il progetto Ecran (European Communication on Research Awareness Needs) che raccoglie guide in sei lingue con film e documenti per sostenere e promuovere la partecipazione a studi clinici, in particolare indipendenti, cercando quella trasparenza scientifica che potrebbe rappresentare l’inizio di una svolta, dalla chiacchiera alla ragione.
di Ferdinando Cancelli